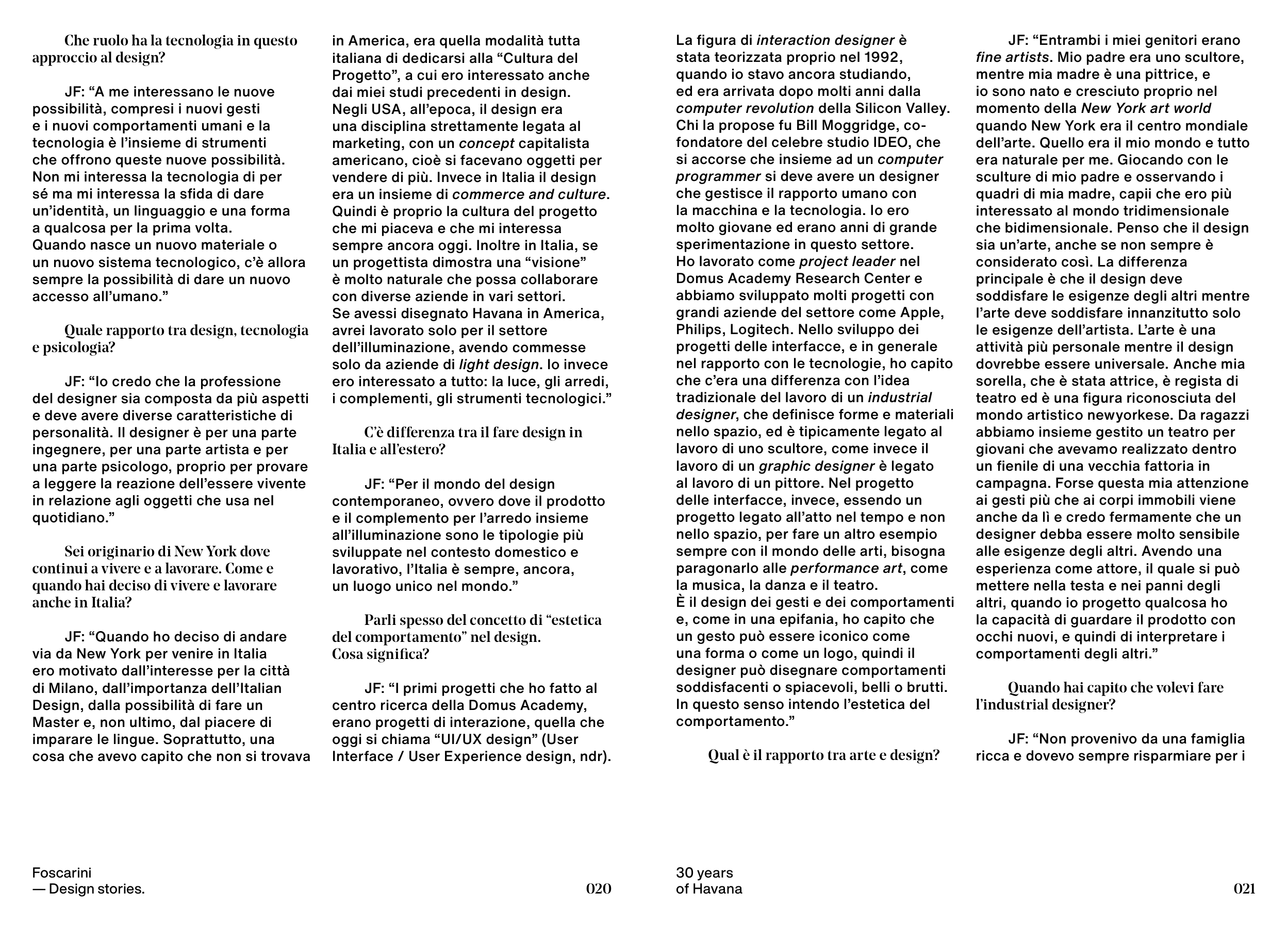020
021
30 years
of Havana
Foscarini
— Design stories.
La figura di interaction designer è
stata teorizzata proprio nel 1992,
quando io stavo ancora studiando,
ed era arrivata dopo molti anni dalla
computer revolution della Silicon Valley.
Chi la propose fu Bill Moggridge, co-
fondatore del celebre studio IDEO, che
si accorse che insieme ad un computer
programmer si deve avere un designer
che gestisce il rapporto umano con
la macchina e la tecnologia. Io ero
molto giovane ed erano anni di grande
sperimentazione in questo settore.
Ho lavorato come project leader nel
Domus Academy Research Center e
abbiamo sviluppato molti progetti con
grandi aziende del settore come Apple,
Philips, Logitech. Nello sviluppo dei
progetti delle interfacce, e in generale
nel rapporto con le tecnologie, ho capito
che c’era una differenza con l’idea
tradizionale del lavoro di un industrial
designer, che definisce forme e materiali
nello spazio, ed è tipicamente legato al
lavoro di uno scultore, come invece il
lavoro di un graphic designer è legato
al lavoro di un pittore. Nel progetto
delle interfacce, invece, essendo un
progetto legato all’atto nel tempo e non
nello spazio, per fare un altro esempio
sempre con il mondo delle arti, bisogna
paragonarlo alle performance art, come
la musica, la danza e il teatro.
È il design dei gesti e dei comportamenti
e, come in una epifania, ho capito che
un gesto può essere iconico come
una forma o come un logo, quindi il
designer può disegnare comportamenti
soddisfacenti o spiacevoli, belli o brutti.
In questo senso intendo l’estetica del
comportamento.”
Qual è il rapporto tra arte e design?
JF: “Entrambi i miei genitori erano
fine artists. Mio padre era uno scultore,
mentre mia madre è una pittrice, e
io sono nato e cresciuto proprio nel
momento della New York art world
quando New York era il centro mondiale
dell’arte. Quello era il mio mondo e tutto
era naturale per me. Giocando con le
sculture di mio padre e osservando i
quadri di mia madre, capii che ero più
interessato al mondo tridimensionale
che bidimensionale. Penso che il design
sia un’arte, anche se non sempre è
considerato così. La differenza
principale è che il design deve
soddisfare le esigenze degli altri mentre
l’arte deve soddisfare innanzitutto solo
le esigenze dell’artista. L’arte è una
attività più personale mentre il design
dovrebbe essere universale. Anche mia
sorella, che è stata attrice, è regista di
teatro ed è una figura riconosciuta del
mondo artistico newyorkese. Da ragazzi
abbiamo insieme gestito un teatro per
giovani che avevamo realizzato dentro
un fienile di una vecchia fattoria in
campagna. Forse questa mia attenzione
ai gesti più che ai corpi immobili viene
anche da lì e credo fermamente che un
designer debba essere molto sensibile
alle esigenze degli altri. Avendo una
esperienza come attore, il quale si può
mettere nella testa e nei panni degli
altri, quando io progetto qualcosa ho
la capacità di guardare il prodotto con
occhi nuovi, e quindi di interpretare i
comportamenti degli altri.”
Quando hai capito che volevi fare
l’industrial designer?
JF: “Non provenivo da una famiglia
ricca e dovevo sempre risparmiare per i
Che ruolo ha la tecnologia in questo
approccio al design?
JF: “A me interessano le nuove
possibilità, compresi i nuovi gesti
e i nuovi comportamenti umani e la
tecnologia è l’insieme di strumenti
che offrono queste nuove possibilità.
Non mi interessa la tecnologia di per
sé ma mi interessa la sfida di dare
un’identità, un linguaggio e una forma
a qualcosa per la prima volta.
Quando nasce un nuovo materiale o
un nuovo sistema tecnologico, c’è allora
sempre la possibilità di dare un nuovo
accesso all’umano.”
Quale rapporto tra design, tecnologia
e psicologia?
JF: “Io credo che la professione
del designer sia composta da più aspetti
e deve avere diverse caratteristiche di
personalità. Il designer è per una parte
ingegnere, per una parte artista e per
una parte psicologo, proprio per provare
a leggere la reazione dell’essere vivente
in relazione agli oggetti che usa nel
quotidiano.”
Sei originario di New York dove
continui a vivere e a lavorare. Come e
quando hai deciso di vivere e lavorare
anche in Italia?
JF: “Quando ho deciso di andare
via da New York per venire in Italia
ero motivato dall’interesse per la città
di Milano, dall’importanza dell’Italian
Design, dalla possibilità di fare un
Master e, non ultimo, dal piacere di
imparare le lingue. Soprattutto, una
cosa che avevo capito che non si trovava
in America, era quella modalità tutta
italiana di dedicarsi alla “Cultura del
Progetto”, a cui ero interessato anche
dai miei studi precedenti in design.
Negli USA, all’epoca, il design era
una disciplina strettamente legata al
marketing, con un concept capitalista
americano, cioè si facevano oggetti per
vendere di più. Invece in Italia il design
era un insieme di commerce and culture.
Quindi è proprio la cultura del progetto
che mi piaceva e che mi interessa
sempre ancora oggi. Inoltre in Italia, se
un progettista dimostra una “visione”
è molto naturale che possa collaborare
con diverse aziende in vari settori.
Se avessi disegnato Havana in America,
avrei lavorato solo per il settore
dell’illuminazione, avendo commesse
solo da aziende di light design. Io invece
ero interessato a tutto: la luce, gli arredi,
i complementi, gli strumenti tecnologici.”
C’è differenza tra il fare design in
Italia e all’estero?
JF: “Per il mondo del design
contemporaneo, ovvero dove il prodotto
e il complemento per l’arredo insieme
all’illuminazione sono le tipologie più
sviluppate nel contesto domestico e
lavorativo, l’Italia è sempre, ancora,
un luogo unico nel mondo.”
Parli spesso del concetto di “estetica
del comportamento” nel design.
Cosa significa?
JF: “I primi progetti che ho fatto al
centro ricerca della Domus Academy,
erano progetti di interazione, quella che
oggi si chiama “UI/UX design” (User
Interface / User Experience design, ndr).